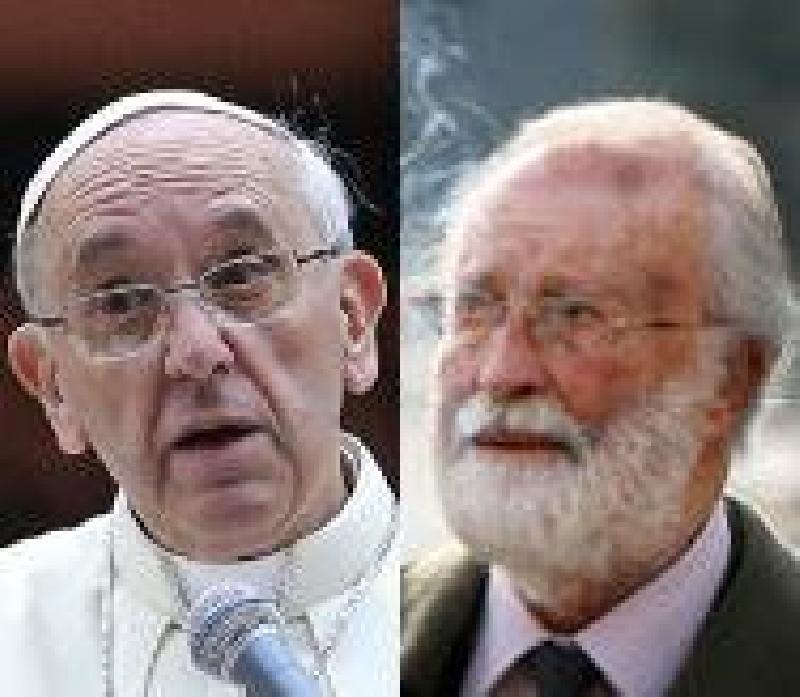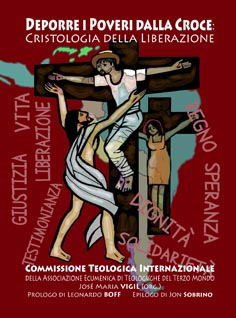di Diego Fusaro
Si è recentemente svolto, sulle pagine di “La Repubblica”, un dialogo epistolare tra Papa Francesco ed Eugenio Scalfari. Si tratta di un avvenimento importante, su cui occorre soffermare l’attenzione, sia pure da una prospettiva differente rispetto a quella che si è imposta come egemonica negli scorsi giorni.
Ho già affrontato la questione in una lunga intervista apparsa – a cura di Moreno Pasquinelli – sul blog “Sollevazione” e, pertanto, in questa sede non farò altro che riprendere cursoriamente alcuni punti che reputo particolarmente degni d’attenzione e che, in quell’intervista, ho sviluppato più estesamente. In primo luogo, merita di essere analizzata la tragicomica inversione delle parti a cui si è assistito: dialogico, aperto, denso di dubbi e di incertezze, il Papa; dogmatico, pontificante e senza la minima incertezza, Scalfari.
Prescindendo dalle tesi esposte e dalla notorietà dei due personaggi, a leggerli si sarebbe potuti plausibilmente essere indotti a ritenere che, tra i due, il pontefice non fosse Bergoglio. Il fondatore di “Repubblica” si pone oggi come pontefice di una religione atea e scientista, intollerante verso ogni forma di sapere che non sia quello piegato ai moduli della ratio strumentale, sotto i cui raggi risplende l’odierna barbarie della finanza e dell’austerity, dell’eurocrazia e della religione neoliberale.
Tale religione promuove compulsivamente il disincantamento e il congedo dalle utopie, la riconciliazione con la realtà presentata come inemendabile, la precarietà come stile esistenziale e lavorativo, l’abbandono del pathos antiadattivo e dell’attenzione per la questione sociale, il culto demenziale dell’antiberlusconismo come unica fede politica possibile: essa è la prova di quanto vado sostenendo da tempo, ossia che il capitalismo si riproduce oggi culturalmente a sinistra (è la tesi al centro del mio saggio Minima mercatalia. Filosofia e capitalismo, a cui mi permetto di rimandare per eventuali approfondimenti). Si pensi anche solo alla trasformazione dei costumi – propugnata urbi et orbi dalla sinistra – in vista di una società interamente liberalizzata, postborghese e postproletaria, individualistica e iperedonistica, affrancata dalla morale borghese e dalla religione.
Anche in quest’ottica, destra e sinistra si rivelano pienamente interscambiabili: l’anticomunitaria e globalista “Destra del Denaro” detta le regole econonomico-finanziarie tutelanti gli interessi della global class, mentre la “Sinistra del Costume” – espressione dell’ideale del comunismo in un uomo solo, trasformando quest’ultimo in atomo di volontà di potenza innervata dal capitale – fissa i modelli e gli stili di vita funzionali alla riproduzione del sistema dell’integralismo economico.
Coerente con questa visione del mondo, Scalfari parla dell’inesistenza di Dio con una sicurezza dogmatica che andrebbe resa oggetto d’attenzione (e che, con buona pace del coro virtuoso dei sedicenti neoilluministi, nulla ha a che vedere con la matrice culturale dell’illuminismo critico). Analogamente, il pontefice di “La Repubblica” rivela una fascinazione quasi commovente – e, a suo modo, teologica – per la scienza innalzata a verità ultima.
Se anche è troppo presto, forse, per valutare l’operato del nuovo Papa, certo è possibile individuare in lui, con diritto, un profilo complessivo non affine alla visione dominante della ragione, ossia quella della ratio strumentale su cui – come ricordavo poc’anzi – si fonda l’odierna teologia economica. Questo è già, di per sé, un aspetto ampiamente positivo, da valorizzare massimamente in una prospettiva che individui il nemico principale non nella fede, ma nella ratio strumentale stessa, che tutto riduce a quantità misurabile, calcolabile e trasformabile in profitto. Si veda, a questo proposito, lo splendido discorso pronunciato dal pontefice a Cagliari domenica 23 settembre, tutto centrato sui temi del lavoro e della dignità offesa dalla disoccupazione coessenziale al regime neoliberale.
Temo che questo concetto – di per sé chiaro come il sole – non passerà facilmente presso l’armata Brancaleone dei cosiddetti “laicisti”. Illudendosi che il gesto più emancipativo che possa darsi sia la ridicolizzazione del Dio cristiano (o, alternativamente, la soppressione del crocifisso dalle scuole), essi non cessano di contrastare tutti gli Assoluti che non siano quello immanente della produzione capitalistica, il monoteismo idolatrico del mercato: il laicismo integralista, in ogni sua gradazione, si pone come il completamento ideologico ideale del fanatismo del mercato e del “cretinismo economico” (secondo la stupenda espressione di Gramsci), in cui “The Economist” diventa “L’Osservatore Romano” della globalizzazione capitalistica e le leggi imperscrutabili del Dio monoteistico divengono le inflessibili leggi del mercato mondiale.
Capirà mai l’armata Brancaleone dei laicisti che la lotta contro il Dio tradizionale è, essa stessa, uno dei capisaldi dell’odierna mondializzazione capitalistica, la quale si regge appunto sulla neutralizzazione di ogni divinità non coincidente con il monoteismo mercatistico?
Riusciranno mai costoro, inguaribili lavoratori per il re di Prussia, a comprendere che ciò di cui più si avverte il bisogno, oggi, è un nuovo illuminismo che contesti incondizionatamente l’Assoluto capitalistico e l’esistenza di presunte leggi economiche oggettive della produzione, sottoponendo a critica l’onnipervasivo integralismo della finanza? Quando capiranno che l’ateismo, oggi, ha come matrice principale non certo l’aumento della conoscenza scientifica (con buona pace di Odifreddi!), ma il processo di individualizzazione anomica che disgiunge l’individuo da ogni sostanza comunitaria? E, ancora, che la “morte di Dio” da loro salutata con entusiasmo corrisponde al momento tragico della perdita di ogni valore in grado di contrastare il dilagante nichilismo della forma merce?